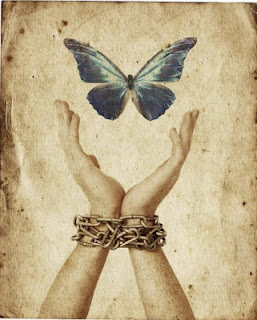LIBERTA'
Questo è un post diverso dal solito, sia per importanza del tema che per mole di lavoro che ci sta dietro. A chi decidesse di leggerlo chiedo perciò di non farlo superficialmente. Piuttosto è meglio non leggerlo. Mi sono avvalsa di molti testi (oltre che del mio pensiero, limato lungo l’intera esistenza), ma sono soprattutto debitrice nei confronti del lavoro di Simone Weil.
Si fatica a parlare di libertà, secondo il mio modo di vedere, perché non esistono condizioni sufficienti per realizzarla. Esistono solo condizioni necessarie. Per cui l’unica cosa che possiamo tentare di fare, è di delimitare una zona di pensiero in cui certamente esiste il “concetto” di libertà. E’ un po’ come per certe particelle: la teoria dice che esistono, per cui quello che possiamo fare è cercare di provarne l’esistenza. Si tratta di un pensiero debole, secondo l’approccio filosofico contemporaneo.
La libertà è un “qualcosa” che se la guardi non la vedi. Occorre esplorare il contorno,
e raggiungerla per sottrazione.
L’uomo si sente fatto per la Libertà. Ed è un Essere pensante (anche se spesso
non sembra; mi si perdoni la stilettata),
e quindi non è possibile che accetti l’idea di non essere libero.
Da sempre sogna la libertà, sotto forma di una felicità
della quale sarebbe stato ingiustamente privato.
L’uomo immagina quindi che possa esistere una felicità nel suo futuro,
che sia dovuta come risarcimento o come dono della provvidenza.
Il comunismo teorizzato da Marx è la forma compiuta più recente di questo sogno.
Il Sogno è sempre rimasto sogno. Come tutti i sogni.
Anzi: potrei dire che il suo valore sta proprio nel fatto di essere
un sogno, perché in tal modo può funzionare da consolazione.
Bisognerebbe rinunciare a sognare, e decidersi ad iniziare ad elaborare.
Dobbiamo provare a concepire, idealmente, cosa possa essere la libertà,
non tanto perché si possa pensare di realizzarla, ma solo per poter sperare di raggiungere una condizione mena imperfetta di quella che conosciamo.
Un miglioramento è concepibile solo paragonando il nostro stato attuale
ad una condizione ideale, e perciò necessariamente irraggiungibile.
L’ideale è altrettanto irraggiungibile del sogno, ma c’è una differenza capitale:
l’ideale è in rapporto con la realtà.
La libertà ideale non può essere pensata come scomparsa della necessità.
La necessità inseguirà l’uomo fino alla sua estinzione.
Perché non è possibile avere tutti i piaceri che si desiderano, ed evitare ogni fatica.
In natura ci sono tempi o luoghi in cui la pressione della “necessità” si avverte in modo più o meno pesante, ma non esiste una soluzione miracolosa che permetta di eluderla ovunque e una volta per tutte.
Se si ragiona con attenzione ci si accorge che questa idea di libertà (presente ovunque ed eterna) è anche abbastanza repellente.
L’assenza di ogni necessità non è una cosa auspicabile. Basta riflettere sul fatto che la debolezza è uno dei tratti caratteristici della natura umana, per comprendere che una vita dalla quale la nozione stessa di fatica fosse pressoché scomparsa, sarebbe inevitabilmente preda delle passioni.
Non c'è padronanza di sé senza disciplina, e non c'è altra fonte di disciplina per l'uomo oltre lo sforzo richiesto dagli ostacoli esterni. Un popolo di oziosi potrebbe anche divertirsi a crearsi degli ostacoli, a esercitarsi nelle scienze, nelle arti, nei giochi; ma gli sforzi che procedono dalla sola fantasia non costituiscono per l'uomo un mezzo per dominare le proprie fantasie. Sono gli ostacoli con i quali ci si scontra e che occorre superare, a fornire l’occasione per vincere se stessi.
Anche le attività in apparenza più libere hanno valore solo nella misura in cui imitano il rigore.
Senza un modello (che viene fornito inconsapevolmente da colui che fatica per vivere)
esse sprofonderebbero nel puro arbitrio.
L'unica libertà ideale è quella di cui godrebbero i bambini piccoli se i genitori non imponessero loro delle regole.
Si tratta di una sottomissione incondizionata al capriccio.
Se non ci fossero i limiti imposti dal pericolo e dai bisogni, l’uomo sarebbe preda delle emozioni, e nulla potrebbe più difenderlo.
Se per libertà si dovesse intendere la semplice assenza di ogni necessità, questa parola (libertà) sarebbe svuotata di ogni significato.
Allora l'esserne privati non significherebbe più che la vita perde il suo valore.
Si può intendere allora per libertà qualcosa di diverso dalla possibilità di ottenere senza sforzo ciò che piace.
La libertà autentica non e definita da un rapporto tra il desiderio e soddisfazione, ma da un rapporto tra il pensiero e l'azione: sarebbe completamente libero l'uomo le cui azioni procedessero tutte da un giudizio preliminare concernente il fine che egli si propone, e il concatenamento dei mezzi atti a realizzare questo fine.
Non importa che le azioni in se stesse siano agevoli o dolorose, e poco importa anche che esse siano coronate da successo; il dolore e la sconfitta possono rendere l'uomo sventurato, ma non possono umiliarlo finche è lui stesso a disporre della propria facoltà di agire.
Disporre delle proprie azioni non significa affatto agire arbitrariamente;
le azioni arbitrarie non derivano da alcun giudizio e, se vogliamo essere precisi, non possono essere chiamate libere. Ogni giudizio si applica a una situazione oggettiva, e di conseguenza alla “necessità”.
Servitù e libertà.
I due termini non sono che i poli ideali tra i quali si muove la vita umana senza poterne mai raggiungere alcuno.
Un uomo sarebbe totalmente schiavo se tutti i suoi gesti procedessero da una fonte diversa dal suo pensiero.
Quanto alla libertà completa,se ne può trovare un modello astratto in un problema di geometria ben risolto; perché in un problema tutti gli elementi della soluzione sono dati, e l'uomo può attendersi aiuto solo dal suo giudizio, l'unico capace di stabilire tra questi elementi il rapporto che costituisce per se stesso la soluzione ricercata.
Gli sforzi e le vittorie della matematica non oltrepassano i limiti del foglio di carta, una vita interamente libera sarebbe quella in cui tutte le difficoltà reali si presentassero come una sorta di problemi risolvibili. Tutti gli elementi del successo sarebbero allora noti e manipolabili. La realizzazione di qualsiasi opera consisterebbe in una combinazione di sforzi cosciente e metodica.
L'uomo avrebbe la propria sorte in mano. Avrebbe potere in ogni istante sulle condizioni della propria esistenza mediante un atto del pensiero.
Il semplice desiderio non lo condurrebbe a niente; non otterrebbe nulla gratuitamente; e anche le possibilità di uno sforzo efficace sarebbero per lui strettamente limitate. Ma il fatto stesso di non poter ottenere nulla senza aver messo in azione, per conquistarlo, tutte le energie del pensiero e del corpo, permetterebbe all'uomo di svincolarsi per sempre dalla presa cieca delle passioni.
Una visione chiara del possibile e dell'impossibile, del facile e del difficile, delle fatiche che separano il progetto dalla messa in opera, è sufficiente a cancellare i desideri insaziabili e i timori inutili.
Da ciò derivano la moderazione e l’audacia, virtù senza le quali la vita è solo un vergognoso delirio.
Non è possibile concepire nulla di più grande per l'uomo di un destino che lo metta di fronte alla necessità.
Senza che egli possa attendersi qualcosa, se non da se stesso, in modo che la vita sia una perpetua creazione di se stesso da parte di se stesso. L'uomo è un essere limitato a cui non è concesso Essere autore diretto della propria esistenza, a differenza del Dio che si è inventato.
Ma l'uomo sarebbe in possesso dell'equivalente di questa potenza divina se le condizioni materiali che gli permettono di esistere fossero esclusivamente opera del suo pensiero. Questa sarebbe la libertà vera.
Questa libertà è solo un ideale, e non la si può trovare in una situazione reale così come la retta ideale non può essere in alcun modo tracciata.
Ma è utile concepire questo ideale, se possiamo discernere nello stesso tempo quanto ci separa da esso, e quali circostanze ci possono allontanare o avvicinare ad esso.
Il primo ostacolo che si presenta e costituito dalla complessità e dall'estensione del mondo con cui abbiamo a che fare.
E’ impossibile per uno spirito umano tener conto di tutti i fattori da cui dipende il successo dell'azione apparentemente più semplice; qualsiasi situazione consente un indefinito numero di casi fortuiti, e le cose sfuggono al nostro pensiero.
Sembrerebbe che il pensiero possa esercitarsi solo su vane combinazioni di segni, e che l'azione debba ridursi a un procedere totalmente alla cieca. Ma di fatto non e cosi. Certo noi non possiamo mai agire a colpo sicuro; ma questo ha meno importanza di quanto si sia portati a credere. Possiamo agevolmente sopportare che le conseguenze delle nostre azioni dipendano da casi incontrollabili.
Viviamo in un mondo dove l'uomo non deve attendersi miracoli se non da se stesso.
C’è tuttavia una fonte di mistero che non possiamo eliminare, ed è il nostro corpo stesso. L'estrema complessità dei fenomeni vitali può forse essere progressivamente sbrogliata, almeno in una certa misura; ma un'ombra impenetrabile avvolgerà sempre il rapporto immediato che lega i nostri pensieri ai nostri movimenti.
Non è possibile trovare nei fenomeni, in mancanza di una necessità chiaramente concepibile, una regolarità pur approssimativa. Talvolta le reazioni del corpo vivente sono completamente estranee al pensiero; talvolta, ma di rado, ne eseguono semplicemente gli ordini; più spesso eseguono ciò che l'anima ha desiderato senza che questa vi abbia alcuna parte; accade anche spesso che esse accompagnino i voti espressi dall'anima senza corrispondervi in alcun modo; altre volte precedono i pensieri. Non e possibile alcuna classificazione.
Gli uomini primitivi si raffiguravano il rapporto tra l'uomo e il mondo non sotto l'aspetto della necessità, bensì sotto l'aspetto della magia. Tra essi e la rete di necessità che costituisce la natura e che definisce le condizioni reali dell'esistenza, si
frappongono quindi come uno schermo ogni sorta di capricci misteriosi ai quali essi credono di trovarsi sottomessi.
Schiavi rispetto a questi capricci immaginari.
Peraltro spesso oggetto d'interpretazione di sacerdoti e stregoni in carne e ossa. Queste credenze sopravvivono sotto forma di superstizioni e, contrariamente a ciò che amiamo credere, nessun uomo ne è completamente libero.
Non c'è alcuna corrispondenza tra i gesti da eseguire e le passioni; il pensiero deve sottrarsi al desiderio e al timore, e applicarsi unicamente a stabilire un rapporto esatto tra i movimenti impressi agli strumenti e lo scopo perseguito.
Non c'è niente in comune tra la risoluzione di un problema e l'esecuzione di un lavoro anche perfettamente metodico, tra il concatenamento delle nozioni e il concatenamento dei movimenti. Colui che si applica a una difficoltà di ordine teorico procede dal semplice al complesso, dal chiaro all'oscuro; mentre i movimenti di chi vive senza poter far altro che questo (schiavi) non sono gli uni rispetto agli altri più semplici o più chiari, ma semplicemente quelli che precedono sono la condizione necessaria per quelli che seguono.
Colui che applica il metodo non ha bisogno di concepirlo nel momento in cui lo applica. Se si tratta di cose complicate, non può farlo neppure se fosse stato lui stesso ad elaborarlo; perché l'attenzione, continuamente costretta ad applicarsi al momento presente dell'esecuzione, non può in alcun modo abbracciare nello stesso tempo il concatenamento dei rapporti da cui dipende l'insieme dell'esecuzione.
Di conseguenza ciò che viene eseguito non è un pensiero, è uno schema astratto che indica una sequenza di movimenti e, al momento dell'esecuzione, è altrettanto poco penetrabile di una ricetta, o di un rito magico.
Ovviamente, coloro che riproducono indefinitamente l'applicazione di questo o quel metodo di lavoro spesso non si sono data la pena di comprenderlo; del resto accade frequentemente che ciascuno di essi sia incaricato solo di una parte dell'esecuzione, e sempre della stessa, mentre i suoi compagni fanno il resto. Ci si trova quindi in presenza di una situazione paradossale; e cioè che il metodo è presente nell’azione, ma non nel pensiero.
Si potrebbe dire che il metodo ha trasferito la sua sede dallo spirito alla materia.
Di questo i computer sono esempio eloquente.
Poiché il pensiero che ha elaborato un metodo d'azione non ha bisogno d'intervenire nell'esecuzione, è possibile affidare questa esecuzione altrettanto bene o anche meglio a una macchina.
Ci si trova allora davanti al singolare spettacolo di macchine nelle quali il metodo si è così perfettamente cristallizzato da dare l'impressione che siano esse a pensare, mentre gli uomini addetti al loro servizio sono ridotti allo stato di automi.
Si giunge inevitabilmente a perdere di vista il rapporto tra segno e significato.
Ci si trova ad aver risolto un problema senza che lo spirito abbia messo in relazione i dati e la soluzione. Il metodo sembra concernere le cose piuttosto che il pensiero.
Più il progresso della scienza accumula le combinazioni precostituite di segni, più il pensiero è schiacciato, impotente a fare l'inventario delle nozioni che manipola.
Si potrebbe concepire, in astratto, una civiltà in cui ogni attività umana, nell'ambito del lavoro come in quello della speculazione teorica, fosse sottomessa a un rigore matematico, e questo senza che nessun essere umano capisca nulla di quanto sta facendo; la nozione di necessità sparirebbe allora, e in modo più radicale di quanto non sia avvenuto per le popolazioni primitive, che ignoravano la logica.
L'unico modo di vivere pienamente libero sarebbe quello in cui il pensiero metodico fosse all'opera sempre nel corso dell’esistenza.
Sarebbe sufficiente che l'uomo mirasse non più a estendere indefinitamente le sue conoscenze e il suo potere, ma piuttosto a stabilire, nello studio come nel lavoro, un certo equilibrio tra lo spirito e l'oggetto a cui lo spirito si applica.
Soltanto l'uomo può asservire l'uomo.
Gli stessi primitivi non sarebbero schiavi della natura se non vi collocassero esseri immaginari analoghi all'uomo, le cui volontà sono peraltro interpretate da uomini. In questo caso come in tutti gli altri, la fonte della potenza è il mondo esterno; ma se dietro le forze infinite della natura non ci fossero, sia per finzione sia in realtà, volontà divine o umane, la natura potrebbe spezzare l'uomo, ma non umiliarlo.
Nella misura in cui la sorte di un uomo dipende da altri uomini, la sua vita sfugge non solo alle sue mani, ma anche alla sua intelligenza; il giudizio e la decisione non hanno più nulla a cui applicarsi; invece di elaborare e di agire, bisogna abbassarsi a supplicare o a minacciare; e l'anima cede al desiderio e alla paura, poiché non vi sono limiti alle soddisfazioni e alle sofferenze che un uomo può ricevere dagli altri uomini.
Questa dipendenza avvilente non riguarda soltanto gli oppressi.
Se c'è al mondo qualcosa di assolutamente astratto e inaccessibile ai sensi e al pensiero, è la collettività; l'individuo che ne è membro non sembra in grado di coglierla.
Né di esercitare una pressione su di essa.
Perché stupirsi se al posto delle idee s'incontrano solo opinioni, al posto dell'azione una agitazione cieca?
Il pensiero si forma soltanto in uno spirito che si trova a essere solo dinanzi a se stesso; le collettività non pensano affatto. È vero che il pensiero per se stesso non costituisce in alcun modo una forza.
Il pensiero può giudicare, ma non trasformare.
Se si vuole concepire, in modo puramente teorico, una società in cui la vita collettiva sia sottomessa agli uomini considerati in quanto individui e non viceversa, è necessario raffigurarsi una forma di vita materiale nella quale intervengano solo gli sforzi diretti esclusivamente dal pensiero illuminato, e questo implicherebbe che ognuno controllasse se stesso, senza far riferimento ad alcuna regola esterna, non solo l'adattamento dei suoi sforzi all'opera da produrre, ma anche il loro coordinamento con gli sforzi di tutti gli altri membri della collettività. Le collettività non dovrebbero mai essere cosi vaste da oltrepassale la portata di uno spirito umano.
La comunanza degli interessi dovrebbe essere abbastanza evidente per cancellare
le rivalità; e ogni individuo sarebbe in grado di controllale l'insieme della vita collettiva.
Un controllo continuo esercitato da ciascuno renderebbe impossibile ogni decisione arbitraria. In generale la dipendenza degli uomini gli uni dagli altri non implicherebbe più che la loro sorte si trovi in balìa dell'arbitrio, e cesserebbe cosi d'introdurre nella vita umana quel qualcosa di misterioso, poiché ciascuno sarebbe in grado di controllare l’attività di tutti gli altri facendo appello esclusivamente alla sua ragione.
Cosi, oltre alla libertà, si possederebbe un bene ancora più prezioso: l’amicizia.